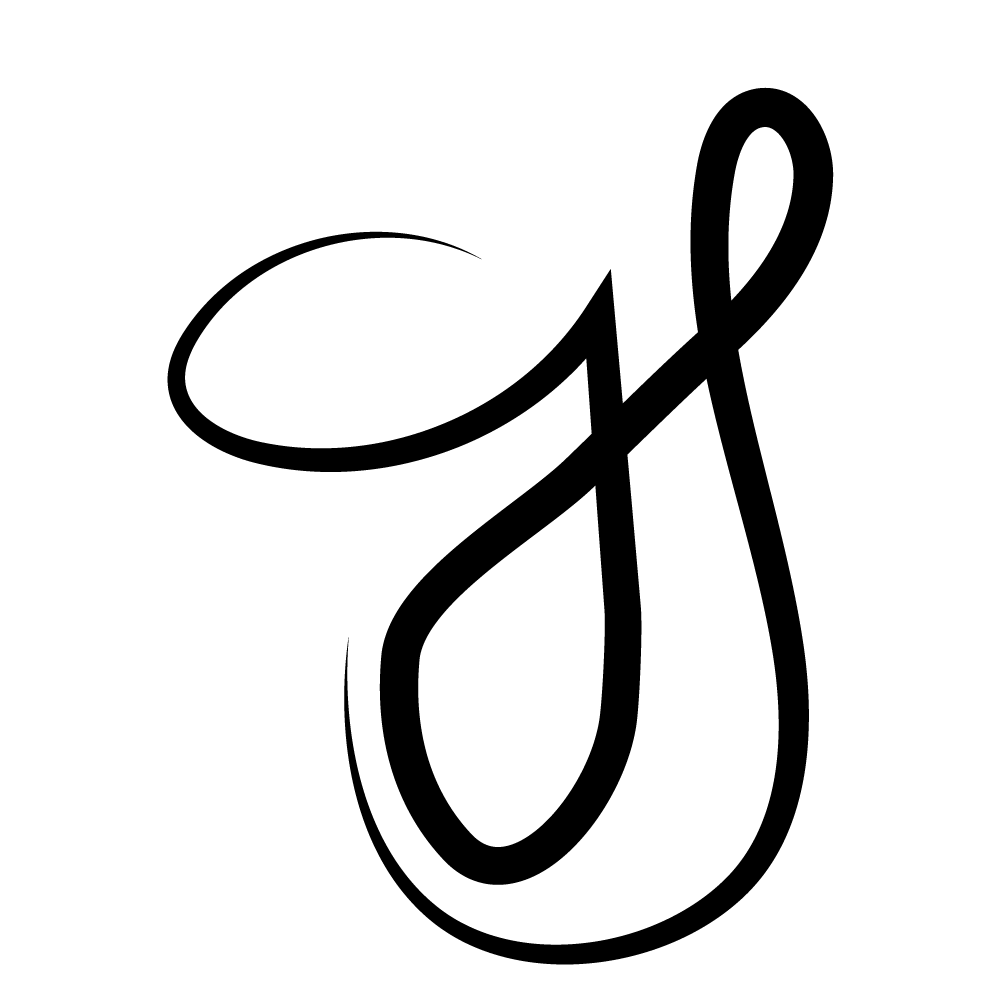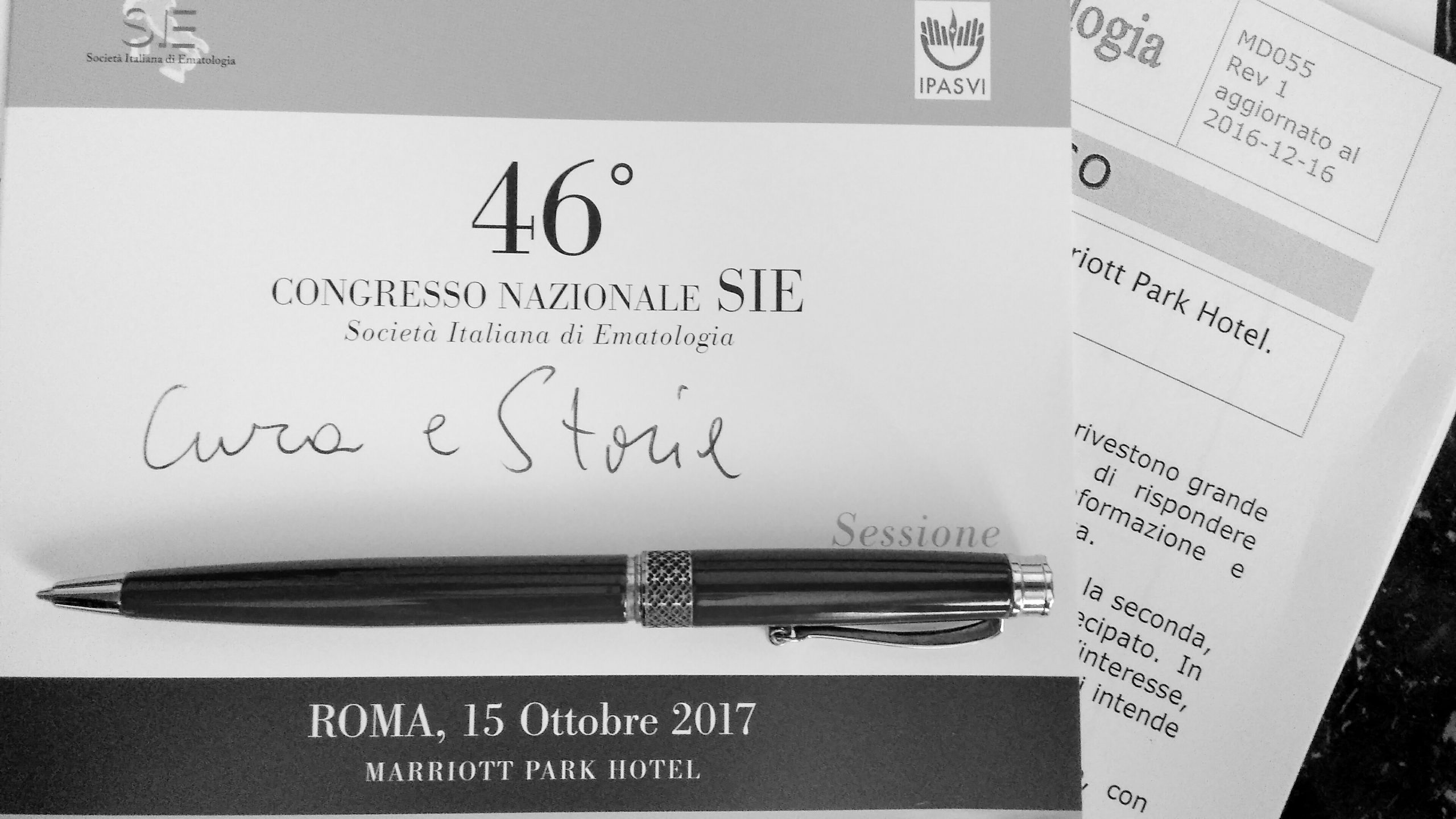Le parole “cura” e “storie” hanno tra loro un rapporto più stretto di quanto possa apparire.
Provate a cercare “cura” su Wikipedia, che di certo non è una fonte affidabile da un punto di vista scientifico, ma ci permette di avere un “insight” una sorta di comprensione sul modo in cui alcuni concetti sono concepiti nella nostra cultura. In Wikipedia “cura” coincide con “terapia”, ovvero “processo mirato a trasformare uno stato patologico in uno stato sano”.
Una definizione scarna, povera al limite del riduzionismo, figlia di un modo di concepire l’essere umano come un aggregato di parti più o meno meccaniche. Molti autori nel corso del secolo passato si sono confrontati con questa idea, concependola in modo molto più complesso e profondo. Martin Heidegger, per esempio: in Essere e Tempo riconosce proprio nella cura, o meglio, nell’attitudine fondamentale all’aver cura di quello che ci sta attorno, la costituzione più profonda e fondamentale dell’essere umano.
La lingua inglese viene in aiuto per capire meglio il concetto di cura. Lo sdoppia in due: “to cure” e “to care”, curare ed aver cura. In contesto medico-sanitario il senso del primo termine è perfettamente chiaro, e coincidente con l’opinione di Wikipedia riguardo a cosa voglia dire “terapia”. Una faccia della cura è quindi oggettiva, pratica: aggiustare cose tangibilmente rotte. L’altra faccia, pur meno concreta, non è meno interessante. Aver cura di qualcuno è meno semplice, meno immediato, meno riducibile a protocolli. Cosa significa aver cura di qualcuno? Come si fa a farlo? No, non c’è nessuna check list. Si tratta soprattutto di una attitudine, di una postura; in sintesi, di prendere a cuore qualcuno. Tutto intero: non “la sua malattia” oppure “la sua sopravvivenza”.
Aver cura di un paziente è fondamentale quanto curarlo. La malattia, specie se grave, crea una cesura nella vita delle persone. Porta scompiglio e disordine. Non è solo un fatto di dolore, di ridotte capacità, o di aspettativa di vita. La malattia ti mette di fronte alla tua mortalità e ti costringe a fare il bilancio della tua vita, a raccontartela per non farla scappare o per tirare le somme. Ecco, per fare questo bilancio c’è un solo modo: raccontarsi la propria storia, oppure, meglio ancora raccontarla a qualcuno che non si limiti ad ascoltarla come si ascolta un programma poco interessante alla radio.
Dal 1946 l’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce “salute” come “uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza dello stato di malattia o infermità”. Ambizioso? Di certo: a prenderla alla lettera nessuno di noi può dirsi in salute. È un’idea asintotica, qualcosa verso cui dovremmo tendere, se vogliamo davvero curare. Non dobbiamo limitarci ad affrontare quello che in inglese si chiama “disease”, la componente “oggettiva” della malattia. Dobbiamo affrontare anche l’illness, ovvero il vissuto soggettivo della persona che ha quella malattia.
Ho scritto che le persone raccontano storie per superare lo scompiglio causato dalla malattia. Rilancio: da un certo punto di vista le persone sono storie. È un filo di parole che ci permette di cucire assieme il passato ricordato ed il futuro immaginato. Ecco perché per chi ha una malattia è così importante raccontare: per fare ordine, per costruire senso in qualcosa che sembra non averne, per comprendersi. Nel peggiore dei casi, per lasciare memoria di sé.
Hans Zinsser, batteriologo morto di leucemia nel 1940, scrisse uno dei suoi sonetti più belli durante i suoi ultimi giorni:
When I am gone—and I shall go before you—
Think of me not as your disconsolate lover;
Think of the joy it gave me to adore you,
Of sun and stars you helped me to discover.
And this still living part of me will come
To sit beside you, in the empty room.
Then all on Earth that Death has left behind
Will be the merry part of me within your mind.
Ecco perché accogliere le storie delle persone di cui abbiamo cura è così importante: perché li mettiamo al centro del processo come persone, appunto, e non come complemento della malattia. Questa forma di alleanza terapeutica non serve solo a ridurre il disagio esistenziale: aumenta l’aderenza terapeutica (anche in categorie notoriamente riottose come adolescenti o anziani), migliora la soddisfazione per le cure ricevute e si riducono le probabilità di malpractice e liti giudiziarie. Curare senza aver cura è somministrare una terapia zoppa. Se curi qualcuno avendone anche cura, beh, allora sì che puoi essere soddisfatto di quello che fai.
Questa presentazione è stata realizzata per il convegno annuale 2017 della Società Italiana di Ematologia.