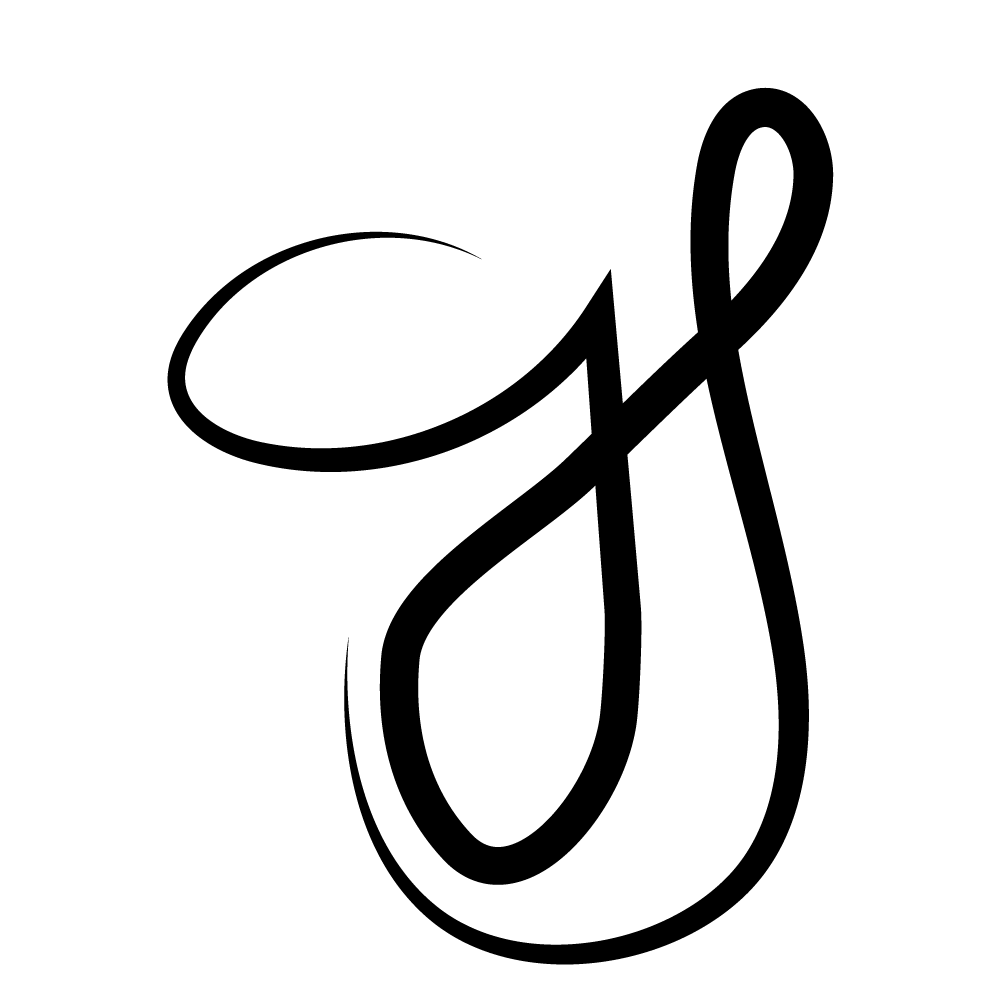“Etica del dono” è solo un piccolo testo, scritto per “Breganze ha un cuore così”, un opuscolo edito dalla sezione indigena della Federazione Italiana delle Associazioni di Donatori di Sangue (mai capito come mai l’acronimo sia FIDAS e non FIADS; suppongo ragioni eufoniche ma chi sa mi illumini). In un numero contenutissimo di battute ho cercato di raccontare la mia relazione con il tema del dono e due importanti “antefatti culturali” di tale concetto. Se, con Leo Strauss, Atene e Gerusalemme sono in simbolo le due radici dell’Occidente, allora il dono, un certo tipo di dono, intero in un certo modo, è parte profonda della nostra identità. Il titolo in effetti è decisamente troppo pretenzioso, ma al momento di inviare il file ero scarso di idee.

Nell’estate del 2009 avevo 21 anni. Ero un giovane capo scout e stavo accompagnando un gruppo di ragazzi lungo l’alta via numero uno delle Dolomiti. Una sera, sotto la Croda del Becco, il sonno tardava a venire e i ragazzi hanno proposto un piccolo momento di rifl essione, uno di quegli attimi di “guardarsi dentro” che, un pò alla volta, la vita adulta tende a rubare. Ognuno di noi aveva un foglio di carta, una penna, ed un compito: stilare una lista che rispondesse ad una domanda.
Quali sono le dieci cose che vuoi assolutamente fare prima di morire?
Messa così sembra una faccenda cupa: è nella natura della nostra civiltà fuggire la morte, scotomizzarne il concetto per esorcizzarne la paura. Ma la morte è inevitabile, ed è proprio la fi nitezza del nostro tempo, il non poter fare infi nite cose, il dover scegliere, a dare senso alle nostre esistenze. Heidegger, in Essere e tempo, lo chiama “esserci per la morte” e sostiene che la morte, come possibilità dell’impossibilità di tutte le possibilità, sia proprio ciò che ci spinge a progettare la nostra vita verso un’espressione autentica del nostro sé. La morte, la consapevolezza del dover morire, è qualcosa che mette ordine, che permette di mettere a fuoco le cose veramente importanti, distinguendole da quelle che lo sembrano soltanto: nessuno, dovendo scrivere un elenco del genere, metterebbe al primo posto qualcosa come “prima di morire voglio assolutamente fare una doccia”; viene invece naturale scegliere cose che diano significato, cose in virtù delle quali, arrivati alla fine, potremo legittimamente dire che la nostra vita è stata una buona vita.
Vorrei salvare la vita a qualcuno: era questo il primo punto del mio decalogo. In altri termini, fare qualcosa che difendesse l’esistenza di un’altra persona avrebbe dato significato alla mia medesima.
Una volta tornato a casa ho iniziato a pensare come realizzare il mio desiderio, perché anche il pensiero più bello ha poco significato, se non si incarna in un’azione pratica, visibile, utile: che valore avrebbero avuto la penicillina, la Gioconda o la Divina commedia, se fossero state solamente immaginate? Dopo qualche mese di ragionamenti, ho deciso che per ottemperare al mio proposito avrei fatto qualcosa di estremamente semplice ed efficace: avrei iniziato a donare il sangue, e mi sarei tipizzato, diventando un potenziale donatore di midollo osseo.
La vita (o il destino, o Dio) non mancano mai di senso dell’umorismo; umorismo che a volte lascia a desiderare. Dagli esami del sangue fatti con l’intenzione di diventare una persona-medicina per qualcuno, è ironicamente emerso che, invece, non solo non avrei mai potuto donare nulla di me, ma che avrei addirittura avuto bisogno in prima persona di qualcuno che avesse fatto la mia stessa scelta: per ragioni ignote avevo perso il novantotto per cento del mio midollo osseo, ed il due per cento residuo aveva smesso di produrre le linee cellulari del sangue, globuli rossi, globuli bianchi e piastrine. Una malattia vigliacca, nota come aplasia midollare idiopatica, mi metteva nella condizione di non poter donare nulla di me. Non solo: la sola cura definitivamente efficace sarebbe stata il trapianto di midollo osseo, ma le probabilità statistiche di trovare un donatore compatibile sono una su centomila.
Senza il trapianto, la mia aspettativa di vita era stimata in dieci anni.
Dieci anni. Dieci anni sono ben pochi, se ne hai ventuno. Niente famiglia, niente figli, niente invecchiare con chi ami al tuo fianco, nessun progetto a lungo termine. E sono i progetti, sono i nostri sogni a farci muovere, a comandare ciascuno dei nostri passi. Come si può vivere senza sogni, senza desideri, senza aspettative? È come essere derubati del bersaglio quando si tira con l’arco: a che cosa si tira? Quanto fa male veder sprecata tutta la forza, tutta l’energia usata per tendere meglio la corda?
Non sono mai stato fortunato giocando contro la probabilità. Per questo gioco a poker e a scopone scientifico: sfi de in cui contano la capacità di leggere il viso degli avversari, di camuffare le proprie espressioni, di ricordare le carte passate. Quell’uno su centomila, la mia persona-medicina, colui (o colei) che avrebbe potuto restituirmi i sogni, le aspettative, il futuro… beh, non c’era. Di conseguenza ho intrapreso un lungo percorso di cure farmacologiche (che continua tutt’ora), con l’obiettivo di far ripartire quello che restava del mio midollo osseo, con la consapevolezza che, anche se fosse andato tutto per il meglio, la soluzione sarebbe stata solo provvisoria.

La chemioterapia non è stata esattamente un giardino di rose, ma comunque ne sono uscito vivo, anche se con questo senso di provvisorietà, di sospensione. Ma non sono capace, non sono mai stato capace di accontentarmi, specie con in gioco un piatto così ricco. La mia persona-medicina non c’è? Allora basta trovarla, basta aumentare il numero di potenziali donatori di midollo osseo. Tanti potenziali donatori non possono che essere un bene, per qualcun altro se non per me. Avrei potuto comunque, in un certo senso indiretto, essere una concausa della salvezza della vita di qualcuno.
Avevo delle idee, prima, riguardo all’etica del dono. Idee frutto dei miei studi filosofici, delle mie esperienze di vita, delle storie di altre persone. Se tra queste dovessi individuarne una di maggior importanza, direi che ho sempre apprezzato il disinteresse, la gratuità, a volte anche l’anonimato del gesto di donare; il solo modo di garantire che un dono sia effettivamente dono e non scambio, oppure anticipo nella speranza di averne in cambio benevolenza o altri vantaggi. Per quanto incredibile possa sembrare, la nostra cultura ne è impregnata sin dalle sue più arcaiche origini: nel mondo greco arcaico, il dono dell’ospitalità, dell’accoglienza, si faceva “al buio”. Quando un ospite inatteso e sconosciuto si presenta sulla soglia, viene ricevuto in silenzio. Gli si offre un bagno, il cibo migliore, il posto d’onore a tavola. Paradossalmente (se non altro per la nostra concezione del dono dell’ospitalità) è il padrone di casa a presentarsi per primo. Solo in seguito rivolge allo straniero le tre canoniche domande – chi sei? Da dove vieni? Dove hai città e genitori? Alla partenza dello straniero, il padrone di casa dona sempre qualcosa di prezioso, un segno tangibile della xeinosyne, la relazione d’amicizia che nasce dall’atto di ospitalità. Esistono numerose testimonianze, in merito, ma una delle più paradigmatiche è contenuta nell’Odissea, quando all’inizio del libro terzo (vv. 34 – 41) Omero descrive l’ospitalità di Nestore a Telemaco, in viaggio per avere notizie del padre Odisseo:
Come videro gli ospiti, tutti corsero in folla,
tesero la mano e li invitarono a prendere posto.
Per primo Pisistrato, figlio di Nestore, accostatosi,
prese la mano di entrambi e li fece sedere a convito,
su morbide pelli di pecora, sulla sabbia del mare,
accanto al fratello Trasimede e al padre.
Diede ad essi poi parti di visceri, versò loro del vino
in una coppa d’oro, […]
Solo in seguito, a banchetto concluso, i padroni di casa interrogano gli stranieri sulle loro origini (vv. 65 – 74)
Quando ebbero cotte e sfilate le terga,
divise le parti, consumarono lo splendido pasto.
Poi, quando ebbero scacciato la voglia di bere e di cibo,
il cavaliere Gerenio, Nestore, tra essi iniziò a parlare:
«Ora certo è più bello domandare e chiedere
agli ospiti, ora che si sono ristorati di cibo, chi sono mai.
O stranieri, chi siete? Da dove venite per le liquide vie?
Per un affare, o alla ventura vagate
sul mare, come i predoni, che vagano
rischiando la vita, portando danno agli estranei?».
Appare chiaro, dalle parole di Nestore, il rischio che corre il padrone di casa: facendo dono della propria ospitalità ad estranei di cui non conosce nemmeno il nome, rischia di portare alla sua tavola predoni ed assassini, ma nonostante ciò Nestore decide di dare fiducia agli stranieri e di accoglierli al meglio delle proprie possibilità.
Nell’orizzonte culturale cristiano, il dono ed il gesto del donare hanno una valenza ancora più forte: Dio stesso, facendosi carne, dona se stesso, il suo sangue, la sua sofferenza e la sua morte al genere umano, e lo fa per offrire la salvezza agli stessi uomini che lo hanno fatto morire sulla croce. Il dono non è per uno specifico gruppo etnico o sociale, ma per tutte le persone che scelgono di compiere un atto di fede. Il sacrificio di Dio per la salvezza dell’umanità intera, nella sua composizione variegata di santi e peccatori, è un dono enorme nella sua sproporzione, alla cui imitazione gli uomini sono decisamente richiamati: è di particolare rilievo, in questo senso, Matteo 5, 43-46:
Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico; ma io vi dico: amate
i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate fi gli del Padre vostro celeste […]
infatti se amate quelli che vi amano, quale merito avete?
In altri termini, che valore c’è nell’amare chi già ci ama? È cosa facile, scontata. La vera sfida sta nell’amare gli Altri, quelli che non ci sono prossimi, che non conosciamo o che ci fanno paura. Difficile non vedere del valore in questa balzana idea, a prescindere dal credere o dal non credere.
Sono tutti concetti di cui si può parlare, a lungo, con molteplici prospettive e testimonianze; fatto sta che, un giorno, stavo ricevendo una trasfusione. Guardavo quel sangue, proveniente da chissà dove, donato da chissà chi, che un po’ alla volta scorreva nelle mie vene, facendomi sentire meglio. Non mi sono chiesto di chi fosse: tutto quello che sapevo era che qualcuno, che non conoscevo e che non mi conosceva, mi aveva amato così tanto da decidere di sacrificarmi una parte di sé.
Posso solo immaginare, purtroppo, cosa si provi stando “dall’altra parte”, dalla parte di chi dona. Molti dei miei amici donano il sangue, quasi tutti sono potenziali donatori di midollo osseo. Alcuni, oltre ad essersi tipizzati, diventando un numero (prezioso come ogni altro) nella grande scatola della probabilità, hanno anche avuto la fortuna di diventare donatori effettivi, perché qualcuno aveva bisogno di loro, e loro soltanto avrebbero potuto fare questa sorta di piccolo miracolo. Hanno affrontato una procedura semplice, sicura e quasi indolore, e adesso, da qualche parte nel mondo, ogni giorno qualcuno si sveglia proprio in virtù del loro gesto. Qualcuno è vivo perché loro hanno detto di sì, perché hanno ritenuto che la vita di qualcuno, chiunque egli fosse, valesse decisamente di più del piccolo disagio del donare. Hanno vinto due volte, perché oltre ad essere stati persone-medicina, oltre ad aver salvato una vita, hanno migliorato la propria. Qualcuno si sveglia in virtù del loro gesto, e loro si svegliano con questa consapevolezza, sapendo che c’è una persona che è ancora viva, che ha riavuto tutti i suoi sogni, i suoi desideri, il suo futuro proprio grazie a loro.
È una consapevolezza che io, purtroppo, posso solo invidiare.
E tu?