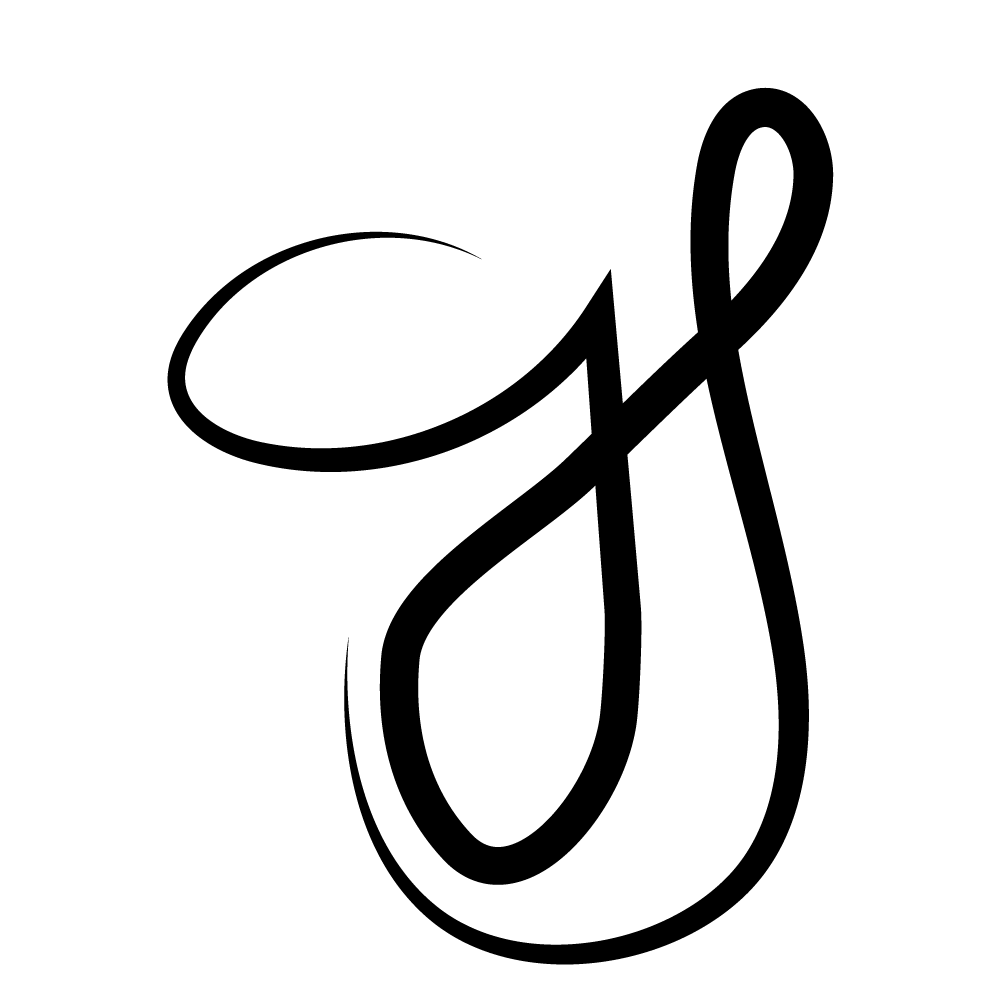Ippolito Pindemonte, Odissea, Proemio (1822)
Musa, quell’uom di moltiforme ingegno
Dimmi, che molto errò, poich’ebbe a terra
Gittate d’Iliòn le sacre torri;
Che città vide molte, e delle genti
L’indol conobbe
In questi giorni bui per il Regno Unito, per l’Europa e per tutto ciò che l’Europa rappresenta, mi piace l’idea di raccontare una storia (che alla fine della fiera è ciò che da sempre gli esseri umani fanno quando è buio). E’ una storia di viaggio, e mi va di iniziarla con una citazione pertinente: certo, sono meno sveglio di Ulisse e non sono stato vent’anni a zonzo, ma Ilio, Troia, era proprio in Turchia, e la Turchia è il posto in cui mi trovavo quando ho conosciuto le persone e pensato i pensieri di cui questo racconto è fatto.
In Turchia. Una persona di buon senso non può non chiedersi cosa ci si vada a fare in Turchia, vicino al confine siriano, in un momento complicato e teso come l’agosto del 2015. La risposta facile, veloce, è che l’Università di Padova mi aveva selezionato come group leader per uno scambio internazionale Erasmus + che avrebbe coinvolto studenti di sei paesi europei, e che quindi avevo vinto un biglietto quasi gratis per vedere quel pezzo di mondo. La risposta corretta è un po’ più complicata, e per capirla bisogna saltellare avanti e indietro nel tempo.

Mamma li Turchi! Plausibilmente è il 1480 quando qualcuno urla queste parole per la prima volta. Tutta colpa di Gedik Ahmed Pasha, Gran Vizir del sultano Mehmet II, detto il Conquistatore per via delle sue manie di grandezza. Insomma, non aveva neppure tutti i torti: se a vent’anni riesci a conquistare Costantinopoli e subito dopo, non pago, scrivi la parola fine alla lunga storia di Bisanzio annettendoti il Despotato di Morea e l’Impero di Trebisonda, beh, è facile trovarsi con un ego ipertrofico.
Ma torniamo al 1480. Mehmet II, bello gasato dai suoi successi in Asia Minore e parecchio indispettito dalla resistenza incontrata in est Europa ad opera di Vlad III di Valacchia (“Tepes” o “Dracula” per gli amici), decide che continuare a litigare con un mezzo zingaro testardo come un mulo e decisamente troppo infoiato con il sadomasochismo estremo non ha senso. Il mondo è grande, per conquistarlo ci sono anche altre strade. Una passa per Otranto.

«Mamma li Turchi!» Ad Otranto qualcuno si piscia addosso mentre, guardando all’orizzonte, lancia il leggendario grido d’allarme. Le 150 imbarcazioni della flotta di Gedik Ahmed Pasha entrano in porto, e due settimane più tardi la sua armata conquista la città. Alla fine dell’assedio gli ultimi 800 difensori di Otranto, sopravvissuti all’assedio, vengono decapitati sul Colle della Minerva.
Nel 1799 lo stesso grido assume un valore diametralmente opposto. Siamo a Palermo, dove il barone Miccichè ospita presso la sua residenza l’ammiraglio turco in visita. Si tratta di un incontro assolutamente pacifico, o quantomeno dovrebbe esserlo nelle intenzioni dei due. Trattative commerciali, diplomazia, un po’ di gossip, insomma, nulla di speciale. Ma la tensione tra cristiani e musulmani è alta da secoli, e basta una scintilla per incendiare la situazione. I resoconti sulla questione non sono precisi, ma pare che un marinaio turco abbia dedicato ad una delle servette di palazzo Comitini più attenzioni di quelle che lei avrebbe desiderato, e tanto è bastato: al grido di «Mamma li Turchi!» si scatena una sorta di pogrom, conclusosi con lo sterminio di tutti i levantini presenti in città, o quantomeno di tutti quelli che non avevano avuto il tempo o il modo di confondersi tra gli autoctoni togliendo il turbante ed imparando a dire «cu nun fa nenti non sbagghia nenti» oppure «ogni cani è lioni na so casa» o perlomeno «vogghio n’arancinu».

Insomma, senza andare a ficcare troppo a fondo il naso nella lunga storia delle relazioni tra turchi e cristiani e prescindendo dal modo, dal tempo e dal contesto in cui si è urlato «Mamma li Turchi!», è palese come tra occidentali e levantini non sia mai scorso buon sangue, ed è facile capire come mai ancora oggi siamo così diffidenti gli uni verso gli altri.
Facciamo un salto avanti nel tempo e un po’ più a nord nello spazio, dimenticando per un momento i Turchi. È il 1914, il giorno di Natale. In Lituania c’è un bambino triste che non ha regali da aprire del quale per ora possiamo perfidamente non curarci.

Ciò che ci interessa non è in Lituania. Accade invece lungo una frontiera divenuta fronte, una delle molteplici ferite aperte dalla Prima Guerra Mondiale che solcano la pelle dell’Europa. Lungo la linea di trincee e filo spinato che divide Francia e Germania succede qualcosa di impensabile: i soldati non si sparano. Anzi! Con la scusa del Natale organizzano cori, veglie a lume di candela, addirittura qualche partitella a calcio, sorta di campionato europeo ante litteram.

Bruce Bairnsfather, un tenente inglese piuttosto dotato per le caricature, racconta quella che sarà ricordata come la Tregua di Natale con queste parole:
Non dimenticherò quello strano e unico giorno di Natale per niente al mondo… Notai un ufficiale tedesco, una specie di tenente credo, ed essendo io un po’ collezionista gli dissi che avevo perso la testa per alcuni dei suoi bottoni [della divisa]… Presi la mia tronchesina e, con pochi abili colpi, tagliai un paio dei suoi bottoni e me li misi in tasca. Poi gli diedi due dei miei bottoni in cambio… Da ultimo vidi uno dei miei mitraglieri, che nella vita civile era una sorta di barbiere amatoriale, intento a tagliare i capelli innaturalmente lunghi di un docile “Crucco”, che rimase pazientemente inginocchiato a terra mentre la macchinetta si insinuava dietro il suo collo.
Le sue parole non sono propaganda allestita ad arte, e neppure il delirio di una persona più sensibile della media spezzata dallo shell shock (gli capiterà, ma pochi mesi dopo, ad Ypres). Anche sull’altro lato del fronte penne meno ispirate testimoniano il fatto; un altro tenente, Johannes Niemann, annota l’accaduto, seppur con meno trasporto e più teutonicissima brevità:
Afferrato il binocolo e scrutato con cautela oltre il parapetto, ebbi la vista incredibile dei nostri soldati che scambiavano sigarette, grappa e cioccolato con il nemico.
È chiaro che combattere una guerra in queste condizioni non è più possibile. Non solo il giorno di Natale, ma anche in quelli successivi le azioni militari si rivelano oltremodo fiacche: gente che spara ai fringuelli, bombe lanciate volontariamente troppo corte o troppo lunghe, assalti alla baionetta rinviati con scuse oltremodo generiche, dalla diarrea alla nebbia. Gli alti comandi ovviamente disapprovano, dopodiché redarguiscono, infine fucilano qualche stronzo hippy ante litteram che mina il morale e la determinazione degli uomini. Il più delle volte si rende addirittura necessario un massiccio cambio di truppe, al fine di sostituire i soldati divenuti incapaci di odiare e di uccidere con truppe fresche, ben fomentate dalla propaganda bellica.
Il punto è che dopo quella notte, dopo quel Natale, chi sta oltre alla frontiera divenuta fronte non è più un mostro ignoto, immaginato sulla base di stereotipi e propaganda militare: è qualcuno con cui si è condiviso qualcosa; diventa un volto, quindi una persona, un altro-da-me. Qualcuno che conosco -e che riconosco- come essere umano; qualcuno che, in ultima istanza, non posso più immaginare di uccidere.
E il bambino triste senza regali da aprire? Si chiama Emmanuel, Emmanuel Levinas. Mi dispiace, niente svolta strappalacrime dickensiana, non è un povero orfano e non è nemmeno stato così cattivo da costringere i suoi genitori a negargli quella bellissima slitta nuova: molto più semplicemente, lui è ebreo, e si sa che gli Ebrei ed il Natale hanno da duemila anni una relazione complicata. In ogni caso, è proprio su questo umano riconoscimento che Levinas fonderà la sua etica: conoscere il volto dell’Altro, coglierne la chiamata e riconoscerlo come altro da sé diventa, nella sua filosofia, il momento in cui l’io si trova costretto a negare la selvaggia ed ingenua libertà del solipsismo, aprendosi alla responsabilità, ovvero alla capacità ed al dovere di rispondere delle proprie azioni.
Ma è il 1914, e Levinas per ora è solo un bambino: servirà l’orrore della Seconda Guerra Mondiale per dipanare la forza dolce e dirompente della sua filosofia.
Premessa: la vita mi ha insegnato a suon di cazzotti nei denti che, tutto sommato, provare a vedere il bene nascosto nel male (per dirla semplice senza perdersi nella metateoresi) non è poi così tanto da poveri stronzi. Ecco, strano (e anche un po’ nazista) a dirsi, ma dobbiamo molto ai massacri indiscriminati che nel secolo scorso hanno insozzato di sangue il nostro continente: saranno infatti proprio le catastrofi belliche del primo Novecento a far maturare la necessità di concepire un’Europa unita, senza più frontiere che possano diventare fronti.
«Mai più» dicono i soldati tornati dal fronte, spezzati nel corpo e nell’anima. «Mai più» urla ogni ferita dei mutilati, ogni città straziata dalle bombe. «Mai più» sommessamente chiedono gli orfani, le vedove.
«Mai più» afferma il Manifesto di Ventotene, il progetto per un’Europa libera ed unita concepito e stilato da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Eugenio Colorni ed Ursula Hirschmann durante i duri anni di confino patiti sotto il fascismo. Di fronte allo sfacelo causato dalle “forze reazionarie” e dalle “ideologie nazionalistiche”, la sola risposta, la sola via per il futuro doveva essere un’Europa federale che spazzasse via autarchie ed isolazionismi, “spina dorsale dei regimi totalitari”, costruendo uno spazio comune in cui uomini nuovi ed opere nuove avrebbero costruito un futuro di progresso, libertà, pace ed uguaglianza.
«Mamma li Turchi!» è una locuzione che negli anni è cambiata nelle forme, rimanendo uguale nei contenuti. Ha conosciuto un incredibile numero di declinazioni linguistiche, etniche, storiche e geografiche, indicando via via come nemici mostruosi popoli, nazioni e fedi differenti: oggi, ad esempio, ha preso le forme dell’«Out! Out! Out!» che nelle strade inglesi si urla in faccia a polacchi, italiani, romeni, più in generale a chiunque non appaia british. Ecco: il progetto europeo, con tutti i suoi limiti e le sue incertezze, non è altro che una versione incredibilmente elaborata e visionaria della tregua di Natale del 1914. Ed è proprio quello lo spirito che, a saper guardare, oggi si ritrova nei progetti Erasmus, nella mobilità internazionale dei giovani: dare l’occasione di conoscere il volto di chi sta oltre al confine, in modo da umanizzarlo, così che non possa mai diventare un mostro senza volto, un Nemico.
Un paio di anni fa giravo tra Italia, Austria e Slovenia, divertendomi a saltare un confine ogni giorno. Vicino a Kranjska Gora, località sciistica slovena, c’è un piccolo passo che permette di raggiungere l’Austria. È una stradina di montagna stretta, poco battuta. In cima, su quel confine, rimangono un carro armato e due file di cavalli di frisia, memoria di quando -fino al 2004- quel confine era una frontiera.

Ho provato un brivido su quella strada, mi sono dovuto fermare a ragionare su come la possibilità di girare il continente da zingari, senza pensieri né passaporti, non sia affatto scontata. È un diritto di valore enorme, conquistato a fatica e da difendere strenuamente. Viviamo un tempo in cui viaggiare fa sempre più paura. Ce lo dicono i media, raccontando ed enfatizzando le tragiche vicende di Valeria Solesin, di Giulio Regeni, delle sette ragazze italiane su quell’autobus ribaltatosi in Spagna. Ma non possiamo – e non dobbiamo – smettere di viaggiare e di far viaggiare la nuova generazione di cittadini europei. Certo, perché sempre più vita e viaggio coincidono, perché solo viaggiando si impara a viaggiare, ma anche e soprattutto perché viaggiare serve a conoscere altri esseri umani ed i loro visi, perché mai più l’Altro possa diventare il nemico.
Non è un caso che in tutta la Gran Bretagna i giovani di buona istruzione -insomma, quelli della “generazione Erasmus”- abbiano votato tendenzialmente a favore della permanenza in Europa: quel voto è la testimonianza di un successo, di come sarebbe sufficiente estenderlo ed iterarlo per non trovarsi mai più a sbraitare una qualsivoglia variante di «Mamma li Turchi!» prima di un pogrom.
Adesso posso chiudere il cerchio, rispondendo a quella domanda lasciata in sospeso. Cosa si va a fare in Turchia, vicino al confine siriano, in un momento teso come l’agosto del 2015? Perché si decide di partire lo stesso, sapendo che avrai treni di armi che ti passano sotto al naso e tuoni lontani di cannonate nelle orecchie?

Si va a far Natale, e sticazzi se non è il momento giusto dell’anno o se lo si festeggia con gente di un’altra religione: si fa Natale come l’hanno festeggiato sul fronte occidentale nel 1914, mentre Levinas non aveva regali da aprire.
Si va a resistere. Alla paura, alla xenofobia, al chiudersi progressivo di frontiere, menti e cuori. In Turchia abbiamo resistito attivamente, facendo un altro -piccolo- passo verso un futuro di pace perpetua, non quella dei cimiteri, ma quella che Kant immaginava nel 1795.
Forse è ora di partire per l’Inghilterra.