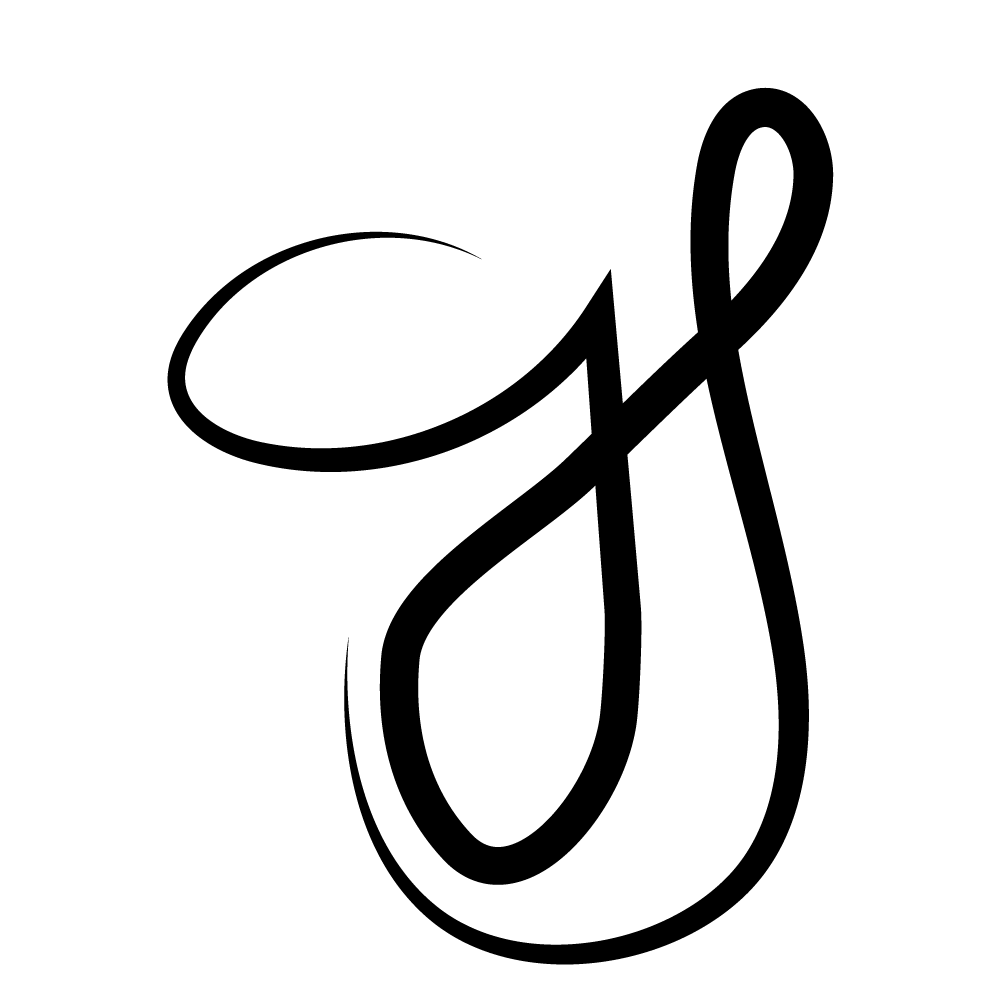Simon Gietl ha scoperto le montagne del Karakorum in un libro: “Ogre”, scritto da Thomas Huber e letto in ospedale, dopo una delle sue prime salite invernali, dall’esito non proprio perfetto. Quindici anni dopo quelle montagne incredibili, marchiate a fuoco nella memoria, si sono materializzate davanti ai suoi occhi: è la realizzazione di un sogno. Una spedizione in Karakorum, il cui obiettivo è la nord del Latok, una cresta tecnicissima ed estenuante che per quarant’anni nessuno ha salito. La compagnia non è da poco: è proprio lo stesso Huber ad accompagnarlo.
Le premesse sono ottime, così come l’acclimatamento, che procede perfetto con la veloce salita ai seimila e cinquanta metri del Panmah Kangri. Ma la vita e la montagna hanno piani diversi.
Avere sogni ambiziosi e realizzarli è una cosa difficile. Ma ce n’è una ancora più difficile: avere sogni ambiziosi e non realizzarli.
Le grandi montagne del Karakorum hanno un fascino particolare, dovuto in gran parte all’estremo isolamento, al sapore di avventura ed alla possibilità di prime salite da pelle d’oca. Hanno nomi mitici, evocativi, misteriosi. le Torri del Trango, per esempio: il Monaco, il Pulpito, il Castello, la Torre Senza Nome. Anche il loro aspetto toglie il fiato: il Laila Peak sembra una lancia conficcata nel cielo, il Masherbrum è una piramide così perfetta che sembra scolpita da mani titaniche. Le montagne del Karakorum, quando le vedi, ti si imprimono a fuoco nella memoria.
Le valli che salgono da Askule al campo base del Latok sembrano scavate con uno scalpello sia in basso, dove ancora c’è spazio per coltivare, che in alto, dove ci sono solo ghiaioni nudi e battuti dalle intemperie: solchi ricavati tra pareti altissime e nette, percorsi da torrenti impetuosi, sentieri sui quali anche i muli dal piede più fermo procedono ritrosi.
Quattro figure minuscole salgono veloci e traballanti la valle del Choktoi, arrancando sotto il peso del materiale necessario ad una lunga spedizione. Si tratta di Simon Gietl, Thomas Huber, Yannick Boissenot, e Rainer Treppte. La destinazione è il Latok I: una montagna remota, difficile, bellissima. Thomas è già stato al suo cospetto altre due volte, nel 2015 e nel 2016, senza riuscire a raggiungere la vetta.
Questa è una fetta di mondo che il leggendario scalatore tedesco conosce piuttosto bene: la prima salita all’Ogre III e la seconda salita all’Ogre, cime poco distanti, portano la sua firma, per esempio. Simon Gietl invece è alla sua prima volta in Pakistan. La vita è buffa, a volte: ti innamori di un posto che non hai mai visto leggendone in un libro, e poi ti trovi ad esplorarlo con chi quel libro lo ha scritto.
Si, perché è così che è andata, è questo il modo in cui le montagne del Latok si sono scolpite nella memoria di Simon: erano i primi anni Duemila, e l’altoatesino aveva appena scoperto il suo sconfinato amore per l’arrampicata, per caso, grazie ad un anonimo alpinista che gli ha dato un passaggio mentre lui faceva l’autostop da Brunico a Dobbiaco. Già dopo le prime poche salite gli era venuta la curiosità di vedere come fosse scalare in inverno, ed eccolo quindi ingaggiato con un collega sullo spigolo Abram sul Sella.
Il risultato era stato poco lusinghiero: dieci giorni in ospedale con principio di congelamento alle dita delle mani e dei piedi. Un sacco di tempo libero, da passare a guardare il soffitto, oppure, meglio, a leggere un libro. E quel libro, regalato dal padre, era stato appunto “Ogre”, di Thomas Huber.
I quattro minuscoli omini in mezzo alle montagne colossali e remote hanno raggiunto la loro meta: un’ampia conca glaciale a 4300 metri sul livello del mare, dalla quale, complice l’altra pressione e l’aria di vetro, sembra quasi che la cima del Latok I si possa toccare. Tutto attorno il silenzio bianco e grigio del ghiaccio e del granito. È ora di iniziare l’acclimatamento, prima di tentare l’impresa: sì, perché l’impresa è tutt’altro che semplice. Sono quarant’anni che nessuno riesce a salire il Latok I, e da nord non è ancora mai passato nessuno. Quella cresta, lunga ed estremamente tecnica, è uno dei grandi problemi del Karakorum.
L’inizio si chiama Panmah Kangri ed ha la forma di una piramide di roccia e ghiaccio. È il 20 agosto quando Simon,Thomas, Yannick e Rainer marciano per un giorno tra ghiaia e ghiaccio al fine di stabilire un campo base avanzato, a 5000 metri, su un pulpito che domina la valle. La sveglia suona presto, alle due. Tempo di trangugiare una colazione frugale ed è tempo di mettersi in marcia, in silenzio, ciascuno solo nel cono di luce della propria frontale e dei propri pensieri. La parete ghiacciata sale ripida, ma la cordata avanza veloce.
L’alba arriva su un piccolo plateau nevoso, uno di quegli angoli di mondo fuori dal mondo in cui la Natura ti parla con voce chiara ed imperiosa fatta di luce e di vento, imponendoti meraviglia e capo chino, come e più che durante una funzione religiosa. Un lungo traverso su granito perfetto, metro dopo metro da ovest a sud-est, e la via per la cima è chiara. Sono le 8:00 quando tutti quattro si stringono la mano e si abbracciano in cima ai seimila metri del Panmah Kangri, e la loro salita è la terza che la storia ricordi.
Il secondo passo di questo gioco progressivo è il Latok III, cima sorella dell’obiettivo della spedizione. Ma la Natura ha opinioni divergenti, in merito: la finestra di alta pressione e di aria di vetro termina bruscamente, scatenando tre settimane di vento e neve. Al campo base c’è poco da fare: cucinare, leggere, tenersi in forma per quanto possibile. Ma la neve sulle cornici continua ad aumentare, così come la frequenza delle valanghe, unica voce a duettare con quella del vento.
Simon e Thomas sono pronti, ma la montagna non lo è. Ed un buon alpinista deve saperne ascoltare la voce, deve essere in grado di capire quando è ora di dire basta, quale sia la soglia del rischio a cui è accettabile esporsi. Soprattutto se a casa ti aspettano moglie e figli.
Si smonta il campo base. Anche quest’anno non è andata. Non è una cosa triste: non tornare a casa è triste, così come lo è tornarci in una cassa zincata.
Tornare a casa dopo una decisione di questo tipo, dopo aver accettato di non realizzare i propri sogni, o per lo meno non ancora, può essere amaro. Ma è anche una promessa, ed è una porta aperta al futuro. Tornare a casa con un sogno da realizzare ed una nuova solida amicizia non è mai triste.
Licenza
Articolo scritto per Salewa Pure Mountain Blog. © Storyteller-Labs. Tutti i diritti sono riservati.